storia rappresentazioni classiche
Spettacoli -1914-1980
1914-1980: SESSANTASEI ANNI DI UNA GRANDE TRADIZIONE
documentazione PDF
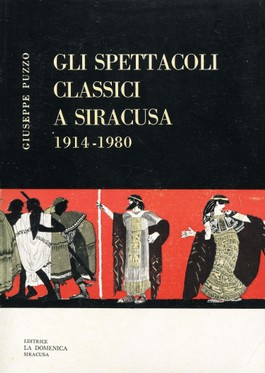
La prima idea di riportare il dramma classico alle sue naturali fonti nei grandi teatri all'aperto dell'antichità viene portata in Italia da Gabriele D'Annunzio nel 1899, dopo che egli ebbe assistito ad una rappresentazione delle "Eumenidi" di Eschilo nel teatro romano di Orange. Il Poeta si entu¬siasma a tal punto della cosa che pensa di costruire un grande teatro all'a¬perto, sulla foggia di quelli antichi, sui colli degradanti verso il Lago di Al¬bano, per rappresentarvi delle tragedie greche. La grande attrice Eleonora Duse, infatuata della geniale idea dannunziana, se ne fa coraggiosa divulga- trice. Il sogno del Poeta e dell'attrice dura pochissimo, ma non se ne perde il ricordo: è come una scintilla. Alcuni anni dopo, infatti, a Firenze, nel 1911, viene gettato il primo fecondo seme per la rinascita del dramma anti¬co. Per iniziativa della Società "Atene e Roma" in occasione del IV Con¬gresso di Studi Classici, viene deciso di mettere in scena nel teatro romano di Fiesole 1' "Edipo Re" di Sofocle, che viene rappresentato il 20 aprile del¬lo stesso anno.
A questa recita fiesolana è presente un giovane patrizio siracusano, il Conte Mario Tommaso Gargallo, il quale sente subito l'importanza della va¬lidità dei problemi e sentimenti umani della tragedia antica nella coscienza contemporanea e comprende l'alta funzione che può avere il tornare a rap¬presentare drammi classici nella cornice naturale che li ha visti vivere di at¬tualità migliaia di anni prima. Rientrato a Siracusa, il Gargallo costituisce, il 6 aprile 1913, con un gruppo di amici, un Comitato cittadino per ripetere nel Teatro Greco di Siracusa, e con maggiori ambizioni, la felice esperienza fiesolana.
Accanto al Gargallo, mecenate animatore, apostolo fervido ed illumi¬nato delle rappresentazioni classiche, è Ettore Romagnoli, insigne grecista, innamorato e studioso dell'arte, riorganizzatore entusiasta delle opere gre¬che, il quale riesce a coinvolgere direttamente amici potenti, studiosi, i gio¬vani allievi di Padova. Il Romagnoli ripropone loro "la festa dell'arte", at¬traverso il contatto con l'eternamente giovane freschezza della immortale poesia greca; egli si prepara in tal modo ad essere mediatore dell'incontro fra il pubblico e il senso del "bello". Dapprima egli opera a Roma, chiamato dal Comitato dell'Esposizione che include nel programma dei festeggiamen¬ti del primo cinquantenario dell'unità nazionale alcune rappresentazioni classiche sul Palatino; subito dopo egli rappresenta al Verdi di Padova le Nu¬vole di Aristofane; dopo Padova passa all'Olimpico di Vicenza e al Rossetti di Trieste; quindi al Teatro del Popolo di Milano, a Fiesole e a Roma; poi sceglie finalmente Siracusa, la "giusta sede". Il Romagnoli chiama Siracusa la "giusta sede" non solo per la presenza in questa città del più grande e più bello teatro greco dell'occidente, ma anche per il suggestivo scenario natura¬le che fa da sfondo a questo insigne e superbo Teatro all'aperto, che trova a Siracusa il suo più alto significato. Il cielo azzurro, la campagna, il mare, i colli, la luce del sole, i tramonti color porpora creano un'atmosfera d'arte e di prodigio e una cornice naturale che al mondo non ha l'eguale. Per questo Siracusa rappresenta la sede adatta, quasi naturale, al rifiorire del dramma classico. Quella del Romagnoli fu davvero una scelta fortunata! Basti pensa¬re al successo strepitoso delle rappresentazioni siracusane, ben definite po¬polari poiché rivolte non ad un pubblico d'élite, ma a tutti, in quanto inter¬preti dei valori umani. Siracusa ha il merito e il privilegio, infatti, non solo di aver concepito la rinascita ed il rifiorire degli spettacoli classici, ma so¬prattutto di aver riportato il dramma greco a contatto con il popolo e di averlo reso popolare. Le rappresentazioni classiche, infatti, richiamano a sè, come ad un rito, il popolo nei suoi strati più diversi, dall'operaio all'uomo di cultura. Quello che era stato patrimonio di pochi intellettuali viene avvi¬cinato profondamente alla sensibilità delle grandi masse a disposizione della loro educazione spirituale. C'è chi ancora considera tali rappresentazioni strumento di educazione popolare, per la corrispondenza con gli interessi intellettuali dei ceti medi e le esigenze ricreative del tempo libero di ogni persona.
L'idea di far rivivere il dramma classico al Teatro Greco di Siracusa vie¬ne attuata il 16 aprile del 1914 dal Comitato per le Rappresentazioni Classi¬che, presieduto dal Conte Gargallo. Uomini di alta cultura ed illustri sono quelli che costituiscono il primo nucleo di ciò che poi diverrà l'Istituto Na¬zionale del Dramma Antico, che trae quindi diretta origine dal Comitato Si¬racusano: tra quest'ultimo e l'Istituto non c'è soluzione di continuità.
L' "Agamennone" di Eschilo, la cui direzione artistica è affidata dal Comitato al gusto e alla passione del Romagnoli, è l'opera che inaugura il felice ciclo delle rappresentazioni siracusane, il cui atto di nascita è bene se¬gnare con l'anno di grazia 1914. I grandi giornali italiani e i più importanti dell'estero riportano a caratteri cubitali il grandissimo successo di questa prima rappresentazione. Il sogno del Gargallo di far rivivere il grandioso Teatro di Siracusa si traduceva in realtà: le dionisiache siracusane erano na¬te! Esse tuttavia sono interrotte per sei anni a causa delle vicende storiche della prima guerra mondiale. Chiusasi questa tragica parentesi, gli spettacoli riprendono con successo nel 1921 con le "Coefore" di Eschilo. Anche per questa rappresentazione Ettore Romagnoli fornisce la traduzione. La ripre¬sa degli spettacoli siracusani nel 1921 è caratterizzata dall'affluire a Siracusa di una folla cosmopolita: si realizzava così anche la felice intuizione del Gargallo che gli spettacoli siracusani non dovevano rimanere un semplice av¬venimento provinciale, ma che dovevano invece assurgere a rinomanza mon diale. I promotori delle rappresentazioni siracusane erano riusciti a interes¬sare a quei primi due spettacoli non solo il mondo intellettuale italiano, ma anche i più eminenti rappresentanti della cultura classica internazionale.
Il successo degli spettacoli del 1921 incoraggia il Comitato Siracu¬sano a ritentare la prova nella primavera successiva. Vengono scelte due tragedie, 1' "Edipo Re" di Sofocle e le "Baccanti" di Euripide. In questi spettacoli viene dato un posto rilevante alla danza e al commento mimico dell'azione: elementi che costituiranno in seguito uno dei fattori più impor¬tanti del successo degli spettacoli siracusani.
Nel 1924 vengono date in un solo giorno, come il primo e il secondo atto di un unico dramma, due tragedie: i "Sette a Tebe" di Eschilo e 1' "An¬tigone" di Sofocle. La danza e l'elemento mimico vengono affidati per la prima volta alle allieve dell'Istituto di danze ritmiche di Hellerau-Laxenburg dirette da Valeria Kràtina.
Il 7 agosto 1925, su proposta del Capo del Governo che aveva assistito entusiasta alle rappresentazioni del 1924, l'Istituto Nazionale del Dramma Antico viene eretto in Ente morale e vengono stabiliti i suoi compiti cultu¬rali ed artistici che assumeranno un'importanza internazionale. Primo Presi¬dente dell'Ente è il Conte Mario Tommaso Gargallo che rimane in carica fi¬no al 1929. In tale anno il Governo chiama a presiedere l'Istituto Biagio Pa¬ce, deputato al Parlamento e professore universitario di archeologia e di sto¬ria dell'arte classica. Ricordiamo che nel mese di marzo 1929 un nuovo Sta-tuto dava un maggiore riconoscimento ufficiale all'Istituto attribuendogli nuovi e più vasti compiti, trasferendone la sede da Siracusa a Roma e inqua¬drandolo definitivamente negli organismi culturali dello stato alle dipenden¬ze dirette del Ministero dell'Educazione Nazionale.
La data del 1927 segna il momento di massima operosità ed efficienza dell'Istituto. Nonostante le notevoli difficoltà tecniche, vengono rappresen¬tati quattro lavori che, nel loro insieme, danno un quadro completo delle tre forme essenziali dell'arte drammatica classica: la tragedia, la commedia e il dramma satiresco. Vengono rappresentati, infatti, la tragedia "Medea" di Euripide, la commedia le "Nuvole" di Aristofane, e i drammi satireschi il "Ciclope" di Euripide e i "Satiri alla Caccia" di Sofocle. In un giorno ven¬gono dati la Medea e il Ciclope; nel successivo le Nuvole e i Satiri alla Cac-cia. Il successo artistico di questi spettacoli siracusani, divenuti definitiva¬mente triennali, è veramente lusinghiero. Essi riescono veramente, dopo tanti secoli, a diffondere nel mondo moderno, attraverso l'universalità e l'u¬manità della tragedia greca, il fascino straordinario e l'eterna validità dei motivi umani ed artistici del dramma greco.
Dal 1929, l'Istituto, pur mantenendo il centro della sua attività nella organizzazione degli spettacoli siracusani, allestisce spettacoli classici in al¬tri teatri antichi della Sicilia e della Penisola, vigilando su ogni iniziativa del genere al fine di mantenere gli spettacoli stessi in un clima di nobiltà e di autentica bellezza. Ma c'è di più: procedendo dalla convinzione che il pub¬blico si interessa di più alle opere solo se ne è adeguatamente preparato, l'Istituto studia il modo di informarlo, attraverso una documentazione il più possibile valida ed oggettiva, dei contenuti, dei valori, degli appunti cri¬tici relativi alle opere rappresentate o da rappresentare. Verso il 1930 sono promossi numerosi incontri culturali al riguardo, è istituita una biblioteca specifica, si dà vita alla rivista "Dioniso", bollettino dell'Istituto del Dram¬ma Antico, unico nel suo genere in Italia e all'estero.
Nel 1930 vengono ancora riprese queste alte manifestazioni artistiche triennali con la messa in scena dell' "Ifigenia in Aulide" di Euripide e 1' "Agamennone" di Eschilo.
Nel 1933 la scelta dell'Istituto cade su due tragedie non ancora appar¬se nei precedenti cicli di rappresentazioni siracusane: L' "Ifigenia in Tauri- de" di Euripide e le "Trachinie" di Sofocle. Impegnativi i programmi del¬l'Istituto, passato nel 1935 sotto la diretta giurisdizione del Ministero della Stampa e Propaganda, per l'ottavo e nono ciclo di spettacoli classici: per il 1936, 1' "Edipo a Colono" di Sofocle e V "Ippolito" di Euripide; per il 1939, r "Aiace" di Sofocle e 1' "Ecuba" di Euripide.
Tanto sviluppo di questo periodo si arresta per la sospensione di ogni attività in seguito allo scoppio della seconda guerra mondiale; alla fine di es¬sa, come già nel 1921, il Teatro si ridesta al calore poetico della trilogia eschilea. Nel 1948, con rinnovato impegno degli organizzatori e con rinno¬vato interesse del pubblico, si ha 1' "Orestea": questa volta, con maggiore intensità che non gli anni passati, tale rappresentazione determina un clima più vivo di senso poetico ed umano, forse per quella serie di spettacoli qua¬li l'Agamennone, le Coefore, le Eumenidi che "sorte da un'unica concezio¬ne poetica presentavano unità di sviluppo drammatico". Presidente dell'Isti¬tuto — dal 1946 al 1950 — è il Prof. Raffaele Cantarella, ordinario di lette¬ratura greca all'Università di Milano.
La gloriosa tradizione teatrale, ripresa nel 1948, ripropone ogni due anni all'attenzione del mondo intero gli eterni testi della tragedia greca, sempre attuale. Nella primavera del 1950 vengono rappresentati i "Persiani" di Eschilo e le "Baccanti" di Euripide.
Oltre al Teatro Greco di Siracusa, dove l'Istituto svolge la sua attività più rilevante, le rappresentazioni classiche si estendono in questo periodo, richiamando sempre più vaste masse di popolo, ad altre località quali Taor¬mina, Palazzolo Acreide, Agrigento, Selinunte, Segesta, Tindari, Paestum, Benevento, Pompei e Ostia Antica.
Nel 1952 l'Istituto, sotto la saggia guida del nuovo Presidente Prof. Antonino Sammartano, che rimarrà in carica fino al 1971, mette in scena le "Troiane" di Euripide e 1' "Edipo a Colono" di Sofocle. Nella lunga gestio¬ne del Sammartano l'Istituto raggiunge le vette più alte portando in scena tragedie mai rappresentate dai moderni perché ritenute dalla critica filologi¬ca ed estetica del tempo poco adatte alla rappresentazione, ma che invece alla prova di scena hanno rivelato una perfetta teatralità ed il loro autentico valore.
Nella primavera del 1954 l'Istituto Nazionale del Dramma Antico (I.N.D.A.) mette in scena, con vivo successo, il "Prometeo" di Eschilo e 1'"Antigone" di Sofocle. Il Prometeo era ritenuto non rappresentabile per¬ché troppo statico e perché posto su un piano divino e quindi impossibile ad essere sentito su quello umano. Anche questa volta l'esperienza della rap¬presentazione supera brillantemente la prova smentendo la congettura di al¬cuni autorevoli critici e filologi che giudicavano la tragedia di scarso rendimento drammatico incapace di commuovere e suggestionare il pubblico mo¬derno perché legata ad un mondo e a un rituale mistico-religioso ormai su¬perato e morto.
Il XIV e il XV Ciclo di spettacoli classici propongono ancora una volta alla attenzione del pubblico rispettivamente 1' "Elettra" e 1' "Ippolito" per il 1956 e F "Edipo Re" e la "Medea" per il 1958. Tutte tragedie già note al pubblico siracusano e riconosciute, per giudizio unanime, di maggiore inte¬resse drammatico e sulle quali, quindi, cade più spesso la scelta.
Nel 1960 P "Orestiade", Punica trilogia della tragedia antica tramanda¬taci, già rappresentata nel 1948, entusiasma il pubblico cosmopolita conve¬nuto a Siracusa. I tre drammi che compongono la trilogia vengono rappre¬sentati nello stesso giorno, come tre atti di una sola opera. Negli anni ses¬santa il successo degli spettacoli classici siracusani è sempre crescente: il pubblico accorre ad essi con una passione e con un impegno veramente ec¬cezionali. Siracusa nelle giornate delle sue "feste classiche" ospita nel suo suggestivo teatro migliaia di spettatori ai quali propone, attraverso l'eterna vitalità ed attualità del dramma greco, in un diretto immediato corale dialo¬go, i temi più angosciosi che in ogni epoca hanno turbato lo spirito umano.
Nella primavera del 1962 vengono rappresentate splendidamente due tragedie di Euripide: "Ecuba", già messa in scena nel 1939, e "Ione" mai rappresentata dall'antichità greca.
Nel 1964, in occasione del XVIII Ciclo di spettacoli classici, l'INDA sceglie due drammi del dolore e della sofferenza mai fino ad oggi rappresen¬tati in Italia, P "Eracle" e P "Andromaca" di Euripide.
Dal 27 al 30 maggio 1965 si tiene a Siracusa il Primo Congresso Inter¬nazionale di Studi sul Dramma Antico. Altri cinque se ne terranno negli an¬ni 1967, 1969, 1971, 1975 e 1977.
Ed eccoci alle rappresentazioni del 1966: vengono riproposte due tra¬gedie riguardanti il mito dei Labdacidi, i "Sette a Tebe" e P "Antigone".
Nel 1968 l'INDA mette in scena due tragedie di Euripide, 1' "Elettra" e le "Fenicie", mai rappresentate a Siracusa.
Nel 1970, in occasione del XXI Ciclo, l'INDA riporta sulla scena 1' "E- lettra" di Sofocle e P "Ippolito" di Euripide, già rappresentati nel 1956. L'Istituto affida la regia dei due drammi a Franco Enriquez.
Il XXII Ciclo di spettacoli classici nel 1972 comprende la realizzazione scenica di due autentici capolavori già rappresentati nel 1958: la "Medea" e P "Edipo Re".
Nuovo Commissario dell'INDA è l'Aw. Diego Gullo, insediatosi nel giugno del 1971.
Nel 1974, ricorrendo il sessantennio delle rappresentazione classiche, l'Istituto riporta sulla scena del grande Teatro siracusano due tragedie di Euripide, P "Ifigenia in Aulide" e le "Troiane". Quest'ultima viene conte¬stata da una parte del pubblico per alcuni inserti di attualità, relativi ad epi¬sodi della guerra del Vietnam e dell'Algeria e della dittatura militare in Gre¬cia, introdotti nella tragedia dal regista De Martino.
A guida dell'INDA è un nuovo Commissario, il Prof. Giusto Monaco.
Il XXIV Ciclo di spettacoli classici nel Teatro Greco e nell'Anfiteatro Romano di Siracusa nel 1976 presenta alcune novità di rilievo: la messa in scena di tre drammi in luogo dei due tradizionali, l'esordio di una comme¬dia latina (Rudens di Plauto), la rappresentazione di una commedia greca (Le Rane di Aristofane), l'utilizzazione dell'Anfiteatro Romano per la rap¬presentazione della commedia latina. L'altro dramma messo in scena è 1' "Edipo a Colono" di Sofocle.
Nel 1978, in occasione del XXV Ciclo di rappresentazioni classiche, l'INDA celebra le nozze d'argento con le sue "feste classiche", mettendo in scena dall'I al 25 giugno due tragedie, le "Coefore" di Eschilo e 1' "Elena" di Euripide, quest'ultima mai rappresentata a Siracusa.
Nel 1980 gli spettacoli messi in cantiere sono: "Le Baccanti" di Euri¬pide e le "Trachinie" di Sofocle.
Con il 1980 chiudiamo il cenno storico sugli spettacoli classici siracu¬sani con la speranza che questo breve riepilogo sia riuscito a dimostrare una cosa molto importante, e cioè che la tragedia greca "trova ancora eco e riso¬nanza profonde nel nostro spirito perché essa è soprattutto espressione di alta poesia nella quale si cala e vive in forme sempre eterne e sempre nuove l'antica anima umana lacerata alla sua radice dal dolore e dal mistero della vita"
(Nino Sammartano — Gli spettacoli classici in Italia).
